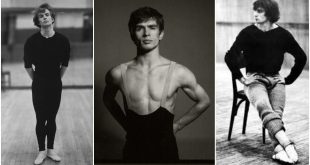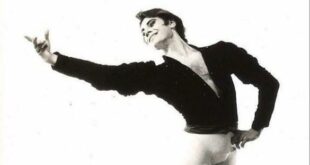C’era un tempo in cui il balletto non aveva la pretesa di essere eterno. Ogni gesto, ogni passo, ogni arabesque svaniva nell’aria appena tracciato. Le coreografie non si scrivevano, si trasmettevano. Vivevano nel corpo di chi danzava e scomparivano con lui.
Eppure, proprio in quell’epoca effimera, tra il marmo dei teatri imperiali e la polvere delle tavole di scena, due uomini hanno scolpito la forma stessa di ciò che oggi chiamiamo balletto classico: Marius Petipa e Lev Ivanov.
Marius Petipa, nato a Marsiglia nel 1818, non era destinato alla Russia, ma fu la Russia a destinarlo al mito. Figlio di un maestro di danza, assorbì il vocabolario teatrale fin dalla culla. Ma fu nel gelo pietroburghese che la sua vocazione trovò forma: la coreografia come architettura.
I suoi balletti – da La Bayadère a Raymonda, da Don Quixote a Le Corsaire – non erano solo danze, ma cattedrali costruite con corpi.
Petipa era un compositore di spazi, un regolatore della geometria scenica. In lui, la danza diventava ordine, disciplina, narrazione mitica.
I suoi celebri pas d’action, la simmetria delle formazioni, il modo in cui coreografava le masse e la narrazione, trasformavano ogni balletto in una macchina teatrale perfettamente oliata.
La sua collaborazione con compositori come Léon Minkus, Riccardo Drigo e, più tardi, Čajkovskij, stabilì l’unità inscindibile tra musica e gesto.
Ma Petipa non era solo rigore: era anche capace di un lirismo nascosto, che affiorava nei momenti sospesi, negli adagi, negli assoli femminili, come nel celebre Pas des Écharpes de La Bayadère.
Eppure, dietro la grandiosità formale, l’uomo si fece sempre più ombra del suo stesso mito, specialmente con l’avanzare dell’età e il mutare del gusto coreografico.
Accanto a lui, Lev Ivanov (1834-1901), uomo più giovane, meno celebrato, ma sottilmente rivoluzionario. Era come l’acqua accanto alla pietra. Più fluido, più spirituale. Se Petipa era l’architetto, Ivanov era il respiro.
Nato a San Pietroburgo, formatosi nella stessa compagnia imperiale, Ivanov rimase spesso nell’ombra, eppure il suo contributo fu decisivo in uno dei momenti più alti della storia del balletto: Il Lago dei Cigni.
Nel 1893, fu Ivanov a coreografare l’Atto II e l’Atto IV nella nuova versione (1895), restituendo all’opera la poesia che il primo allestimento (1877) non aveva saputo esprimere.
L’atto bianco (Atto II) che conosciamo oggi – con le sue onde di cigni, la purezza della linea, il senso del tempo sospeso – è l’impronta di Ivanov, non di Petipa. Lì la danza si fa musica visibile. Il gesto non è più ornamento ma emozione.
Anche l’Atto II de Lo Schiaccianoci, con le sue danze etniche e il celebre Valzer dei Fiori, è opera sua: un merletto coreografico, leggero ma strutturato con rara raffinatezza.
Ivanov era un artista che non reclamava il proprio posto al sole. Firmava lavori a quattro mani, spesso senza ricevere pieno credito, ma lasciava tracce profonde nel linguaggio della danza.
È nella versione del 1895 de Il Lago dei Cigni che le due anime si fondono: Petipa firma l’Atto I e III – gli atti “terreni”, regali, strutturati – mentre Ivanov si occupa degli atti onirici, acquatici, soprannaturali.
Due visioni del mondo in uno stesso balletto: il razionale e il misterioso, il corpo e lo spirito.
Questa bipartizione coreografica è oggi considerata uno dei vertici assoluti del balletto romantico tardo. Ma all’epoca, Ivanov ricevette solo menzioni marginali. Morì in povertà, quasi dimenticato, mentre Petipa – pur ostacolato dagli eventi – veniva ancora onorato.
Oggi gli studiosi tentano di ricostruire, attraverso le notazioni Stepanov, gli appunti, i libretti e le cronache, il contributo autentico di ciascuno. Il dialogo tra Petipa e Ivanov rimane un enigma: due voci diverse, ma profondamente interconnesse.
Petipa è il codice, Ivanov è il sentimento. Il primo ha costruito il palcoscenico del balletto classico. Il secondo ha insegnato a farlo vibrare.
Raccontare Petipa e Ivanov non è solo esercizio filologico, ma atto di giustizia storica. È riconoscere nel bianco e nero delle notazioni, nei passi tramandati oralmente, nei corpi che danzano oggi, la voce doppia di una tradizione: quella che si costruisce con disciplina, ma si anima con sentimento.
In questo equilibrio risiede la voce immortale di due maestri che danzarono nel silenzio della storia per far parlare il movimento.
Michele Olivieri
www.giornaledelladanza.com
©️ Riproduzione riservata
 Giornale della Danza La prima testata giornalistica online in Italia di settore
Giornale della Danza La prima testata giornalistica online in Italia di settore