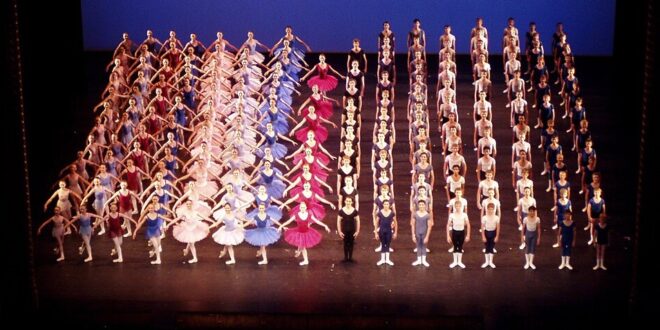Quando si parla di Dirty Dancing, si pensa subito all’iconica scena del sollevamento finale sulle note di (I’ve Had) The Time of My Life, ma la vera forza del film sta nel modo in cui racconta la danza come trasformazione personale, libertà e linguaggio del desiderio. Ambientato nell’estate del 1963, il film segue la crescita di Frances “Baby” Houseman, una ragazza idealista e inesperta che scopre un mondo nuovo grazie all’incontro con l’insegnante di ballo Johnny Castle, interpretato da Patrick Swayze, accanto a Jennifer Grey nel ruolo di Baby. Ma più che una semplice storia d’amore, Dirty Dancing è un racconto di formazione che passa interamente attraverso il corpo e il movimento. Nel resort elegante in cui soggiorna la famiglia di Baby, esistono due mondi separati: quello dei ricchi villeggianti e quello dello staff. La danza è il punto d’incontro – e di scontro – tra queste realtà. I balli “ufficiali” sono composti, eleganti, controllati. Al contrario, le feste notturne dello staff esplodono di ritmo, contatto fisico, improvvisazione. Qui la danza è istintiva, sensuale, quasi ribelle. Baby, entrando in questo spazio proibito, attraversa simbolicamente una barriera sociale. Non sta solo imparando dei passi: sta mettendo in discussione le regole del ...
Read More »
 Giornale della Danza La prima testata giornalistica online in Italia di settore
Giornale della Danza La prima testata giornalistica online in Italia di settore