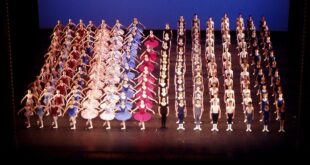Coreografa, performer e autrice di spicco della scena contemporanea, Simona Bertozzi attraversa da oltre quindici anni i territori della danza con uno sguardo rigoroso, aperto alla contaminazione e profondamente sensibile alla dimensione del tempo presente. Fondatrice della compagnia Nexus, il suo percorso si è sviluppato tra contesti nazionali e internazionali, sperimentando linguaggi, collaborazioni e forme sempre nuove di relazione tra corpo, pensiero e spazio scenico. La sua ricerca coreografica è da anni riconosciuta per il rigore e la radicalità. La sua ultima creazione, Altitudine ‒ che sarà presentata il 3 luglio 2025 nell’ambito del Festival Nutida ‒ realizzata con il musicista elettronico Francesco Giomi, nasce da un’esperienza condivisa in Perù e si configura come un dispositivo di improvvisazione totale, in cui corpo e suono si fondono per generare un paesaggio in costante mutazione. Un’opera che rifiuta la forma chiusa per abitare l’ossigeno dell’istante creativo, in cui ogni gesto è un atto di ascolto e ogni suono un’occasione di trasformazione. In questa intervista, Simona Bertozzi ripercorre le radici del progetto, riflette sul proprio percorso artistico e ci accompagna dentro una pratica che fa del movimento una grammatica viva, radicale e in continuo divenire.
Lei ha attraversato la scena coreografica europea formando la Sua poetica tra Italia, Francia, Spagna, Belgio e Regno Unito. In che modo questi contesti hanno influenzato la tua identità artistica?
L’incontro con quei territori europei è avvenuto prima attraverso la pratica, poi come influenza poetica o stilistica. In ciascuno ho avuto modo di confrontarmi con maestr* e coreograf* fondamentali per la mia formazione, soprattutto per quanto riguarda tecniche della danza contemporanea come il floor work, la release technique e la contact improvisation. Pratiche che hanno rappresentato per me una base solida su cui costruire ogni successiva riflessione. A Parigi ho svolto ricerche su Loïe Fuller, nell’ambito della mia tesi di laurea. In Spagna ho lavorato con Tomàs Aragay (Societat Doctor Alonso) a un progetto che ha lasciato un segno profondo nel mio modo di abitare la scena. In Belgio ho avuto modo di avvicinare realtà importanti come quella di Wim Vandekeybus, assorbendo immaginari e pratiche che, pur trasformandosi nel tempo, probabilmente non ho mai abbandonato. Nel Regno Unito ho coreografato per la giovane compagnia Lîla Dance di Eastleigh, È stato importante dirigere la mia ricerca verso un gruppo già coeso, che non conoscevo, osservando come la mia proposta potesse aprirsi a nuovi immaginari e esperienze. Tutto questo ha contribuito a far sì che la mia poetica si articolasse come un sistema poroso, in ascolto, capace di restare in relazione con i cambiamenti sociologici, storici e culturali. Una pratica multiforme, che cerca di mantenere il linguaggio del corpo costantemente allineato alle trasformazioni del presente.
Dal 2008 con la Compagnia Simona Bertozzi | Nexus porta avanti una ricerca autoriale intensa. Quali sono stati i momenti di svolta più significativi in questo percorso?
Ci sono stati percorsi che hanno inciso profondamente sulla mia ricerca, sia dal punto di vista del formato che delle collaborazioni. Uno di questi è Homo Ludens (2009–2012), progetto articolato in quattro episodi ispirati alle categorie ludiche di Roger Caillois. Questa esperienza ha aperto una questione centrale che si è rafforzata nel tempo: il rapporto tra scrittura coreografica ed eterogeneità dei corpi in scena. Anche quando si tratta di interpreti altamente formati, cerco sempre di generare un terzo territorio in cui la mia visione iniziale possa trasformarsi a contatto con le loro prospettive corporee. L’incontro, lo stupore, la traduzione divergente del mio immaginario iniziale sono elementi fondamentali del processo di creazione. Questa direzione si è poi strutturata con il progetto Prometeo (2015–2017), un progetto episodico che ha proseguito l’indagine sul corpo come dispositivo di conoscenza. Non una narrazione del mito, ma la questione della techné declinata in una grammatica generativa tra le presenze in dialogo. And it burns, burns, burns, episodio conclusivo (con musica di Francesco Giomi), vedeva in scena due adolescenti insieme a danzatori professionisti, creando un innesto inatteso tra visioni, corpi e livelli di esperienza. Questa attenzione per l’eterogeneità dei gruppi coinvolti è al centro anche di Athletes, progetto tra danza, sport e vocalità in continua evoluzione dal 2024, con il coinvolgimento di danzatrici, ex atlete e gruppi di donne e cittadinз dei territori incontrati. È un processo che continua a espandersi, nutrendosi di ogni nuovo incontro e riformulando di volta in volta le relazioni tra pratiche e identità. Un’altra direzione sostanziale della mia ricerca riguarda la relazione con la musica dal vivo e il privilegio di aver incontrato, nel tempo, collaborazioni preziose con importanti musicistə. Francesco Giomi è sicuramente in primo piano in questo percorso, con importanti creazioni tra cui, oltre al Prometeo, Anatomia e Joie de vivre. Tutto questo ha ridefinito nel tempo il mio modo di intendere la ricerca e la creazione coreografica. Il confronto con la pluralità dei linguaggi, con contesti eterogenei e con differenti modalità di abitare il corpo, ha reso la mia pratica sempre più aperta, ricettiva e in trasformazione. Un processo che non cerca di fissare forme, ma di costruire condizioni di ascolto e relazione, in cui la coreografia diventa spazio condiviso di attraversamento, risonanza e interrogazione continua.
Nei Suoi lavori, il corpo è spesso un luogo di riflessione filosofica e politica. Come si è trasformato nel tempo il tuo modo di pensare e mettere in scena il corpo?
Il corpo è un dispositivo di relazione, un punto di contatto tra il visibile e l’invisibile, tra il gesto e il suo affetto. Nello spazio della scena il corpo si espone, assume il rischio della vulnerabilità, prende decisioni e diventa presenza attiva, generativa. Penso sempre più alla coreografia come a una ecologia del gesto: una pratica che non riguarda solo il movimento in sé, ma l’insieme delle condizioni che lo rendono vivo. Un corpo in scena non si limita a fare, ma incide, interroga, mette in discussione. In Altitudine, ad esempio,il corpo si misura con l’imprevedibilità dell’istante e con la permeabilità al suono: non produce forma, ma si fa paesaggio in trasformazione, partecipe di un ecosistema performativo che si scrive nel tempo reale. In questo senso, la coreografia diventa una modalità di abitare/fare mondo. Ogni progetto è un tentativo di costruire condizioni di possibilità per l’emersione dell’inaspettato.
La Sua pratica coreografica è sempre aperta al dialogo con altri linguaggi, dalla filosofia alla musica elettronica. Cosa guida le tue scelte di contaminazione interdisciplinare?
Non sono interessata alla narrazione. Cerco piuttosto di creare un territorio fertile, dove i linguaggi si incontrino senza doversi spiegare. La musica elettronica, la filosofia, l’arte visiva – e potrei aggiungere anche la scienza, l’antropologia, lo sport – non entrano nei miei lavori come cornici, ma come materie attive, capaci di generare attrito, tensione, ascolto. Sono canali che amplificano le domande, non strumenti per trovare risposte. Mi interessa il modo in cui una frequenza sonora può alterare una traiettoria, o una parola filosofica può aprire un varco nel movimento, disarticolare un gesto, espanderlo. Ogni linguaggio che entra nella creazione coreografica lo fa per spostare il punto di vista, per mettere in crisi la forma precostituita, per generare slittamenti. Non c’è una gerarchia tra le discipline. C’è un invito a condividere un orizzonte di interrogazione, a far sì che i linguaggi si incontrino nel gesto, nel corpo, nella scena come spazio vivo, attraversabile, non concluso.
La Sua creazione “Altitudine”, che sarà presentata il 3 luglio 2025 nell’ambito del Festival Nutida 2025, è il frutto di un’esperienza condivisa in Perù nel 2019. Cosa ha rappresentato quel contesto per la nascita di questa creazione?
Con Francesco Giomi collaboravo già da alcuni anni, e il viaggio in Perù – particolarmente ricco di suggestioni – ha nutrito la sinergia e suggerito nuove direzioni di ricerca. È stato un momento capace di riattivare risonanze già presenti nel mio percorso e, allo stesso tempo, di aprire immaginari inaspettati. Ricordo in particolare un’escursione al Lago Salinas, una piana di sale situata a 4200 metri. Un paesaggio maestoso, surreale, ultraterreno, che ha trasfigurato le nostre percezioni del suono, del silenzio, del respiro. Il volume del paesaggio era qualcosa di vibrante, impossibile da misurare con i parametri consueti. Altitudine nasce così, da uno scambio immediato, estemporaneo, ma profondamente sedimentato. È il tracciato di un ascolto che si fa forma, in una condizione trasformativa dove l’ambiente, l’incontro e il corpo si ridefiniscono a vicenda. Non c’è stato un lavoro preparatorio in senso stretto, nessuna sala prove, ma una condivisione diretta dell’esperienza, dell’ambiente, dei tempi del corpo e dell’ascolto. Dialogare con la traiettoria sonora di Francesco significa confrontarsi con un doppio movimento: da un lato un sottotesto strutturato, precisissimo; dall’altro una continua possibilità generativa di apertura e imprevedibilità.
Guardando ai Suoi primi lavori e confrontandoli con opere recenti come “Altitudine”, quali cambiamenti riconosce nel Suo modo di creare e abitare la scena? Quest’opera rappresenta un punto di rottura o di continuità?
Credo entrambe le cose. Altitudine porta con sé alcuni tratti riconoscibili della mia ricerca: la presenza radicale del corpo in scena, la composizione in tempo reale come dispositivo di ascolto e attraversamento. In questo senso, si inserisce nel solco di un lavoro che da anni interroga la scena come spazio di relazione e tensione percettiva. Ma al tempo stesso, Altitudine sovverte molte delle regole su cui si è basato finora il mio processo creativo. Rifiuta qualsiasi impianto coreografico strutturato per affidarsi completamente all’immediatezza dell’istante, a una forma che nasce e si consuma nel presente. Non c’è un disegno da rispettare, ma una condizione da abitare. E questa condizione è esposta, fragile, porosa. In questo senso, Altitudine non rompe con il passato: è una continuità che si fa rottura e si radica in una fedeltà alla pratica dell’ascolto e della trasformazione. Non si cerca la forma compiuta, ma la traccia che si dissolve nel momento stesso in cui si manifesta. E questo, per me, è un atto coreografico radicale.
Nel progetto si parla di un incontro tra corpo biologico e corpo sonoro. Come descriverebbe questo dialogo nella pratica scenica?
È un dialogo che si costruisce sulla frizione, sul contrasto, sulla mutazione. Non c’è una guida, né un accompagnamento: piuttosto, una tensione costante tra ciò che accade nel corpo e ciò che accade nel suono. Una reciprocità sensibile, dove l’uno riscrive continuamente l’altro.
L’opera si fonda sull’improvvisazione totale. Che tipo di allenamento o disposizione mentale richiede una creazione tanto aperta all’imprevisto?
Un allenamento alla presenza, al non-attaccamento. Bisogna essere pronti a lasciar andare la forma, a stare nell’instabilità come condizione generativa. È una pratica di vigilanza, ma anche di abbandono. Un equilibrio sottile tra determinazione e permeabilità.
“Altitudine” sembra rifuggire dalla forma compiuta in favore dell’effimero. Cosa cerca di comunicare con questa sospensione del “definitivo”?
Un modo diverso di abitare il tempo. Sospendere il definitivo significa aprire spazi di possibile, sottrarsi alla necessità di concludere, evitare la chiusura come forma di rassicurazione. È un gesto che rifiuta la compiutezza come valore e si affida invece all’ascolto come forma di conoscenza, dove ciò che conta non è ciò che si comprende, ma ciò che si attraversa, si lascia modificare, si lascia essere. Ogni elemento scenico – gesto, suono, respiro – è chiamato a non fissarsi, a restare disponibile, vulnerabile, in transito. Non si tratta di abbandonare la forma, ma di non imporsi una forma definitiva, permettendo al processo di rimanere aperto anche nell’atto della performance. È un invito a non cercare un significato univoco, ma a sostare nell’immediatezza del movimento, nelle sue pieghe, nei suoi vuoti, nei suoi slittamenti. È un paesaggio temporaneo, in cui la materia scenica – corporea e sonora – non dichiara, ma evoca. Preferisce il fragile al risolto, il plurale all’unico. Una pratica di libertà e di responsabilità insieme.
Nel testo si parla di un “paesaggio sensibile in metamorfosi”. Quanto conta per Lei la relazione con lo spazio nei Suoi lavori?
Moltissimo. Lo spazio, per me, è una corporeità attiva, un interlocutore vero e proprio. Non è solo ciò in cui il corpo si muove, ma qualcosa che muove il corpo, che lo sollecita, lo interroga, lo trasforma. Spesso nei miei lavori cerco di ribaltare il punto di vista: non è tanto il corpo che incide lo spazio, ma lo spazio che, attraverso tensioni invisibili e configurazioni dinamiche, attiva il corpo. Questo genera stati di presenza sempre diversi, in relazione non solo alla materia visibile ma anche a ciò che vibra, risuona, devia. In questo senso, il corpo diventa una sorta di tessuto connettivo, un luogo di passaggio, di elaborazione di informazioni che arrivano dall’esterno e vengono trasformate nel gesto. L’interlocuzione con lo spazio è continua, mai scontata: un campo di incisioni, declinazioni, interstizi in cui il movimento si rigenera costantemente. Ogni decisione anatomica – ogni appoggio, ogni direzione, ogni sospensione – è frutto di questa relazione. Ed è proprio nel modo in cui il corpo abita lo spazio, lo ascolta, lo rifrange, che si disegna il processo vivo del movimento: non come forma chiusa, ma come permanenza fluida nella relazione.
La verticalità evocata dal titolo è descritta come tensione verso l’ossigeno dell’istante creativo. Qual è il Suo rapporto con questa idea di “ascensione”?
La intendo come una tensione costante, una spinta verso una soglia percettiva più sottile. In Altitudine, l’ossigeno non è una metafora, ma una condizione reale e sensibile, che modifica il ritmo, la densità, la qualità della presenza. È una rarefazione che apre, svuota, dilata: non eleva, ma espone. Espone il corpo a una dimensione più fragile, più acuta, dove il gesto si assottiglia e allo stesso tempo si intensifica. È un’ascensione che non porta in alto, ma porta altrove. In un luogo dove la forma si alleggerisce e ogni respiro diventa parte di un equilibrio instabile, precario, e proprio per questo fertile. Vorrei aggiungere che la dimensione della verticalità, per noi esseri bipedi, è qualcosa che negoziamo costantemente. Il nostro assetto posturale non è mai definitivo: è frutto di un equilibrio continuamente riposizionato, che si costruisce nella relazione con la forza di gravità. Nonostante la verticalità sia ciò che ci distingue in quanto umani, non è una condizione naturale pienamente compiuta. È, piuttosto, un processo in divenire, una conquista fragile che richiede un lavoro incessante. All’interno del corpo, si attiva una negoziazione invisibile, fatta di assestamenti minimi, micro-spostamenti della colonna vertebrale, variazioni nei punti d’appoggio, nel peso, nell’equilibrio. È una condizione dinamica, una vibrazione continua, che esprime una tensione tra stasi e caduta. La verticalità, allora, non è semplicemente una direzione, ma un’azione che resiste alla caduta. E trovo che sia estremamente interessante riportare questa consapevolezza dentro la pratica coreografica: non come metafora, ma come materia concreta di indagine. Nel lavoro su Altitudine, ad esempio, questa idea di verticalità instabile entra in dialogo con il corpo sonoro. È nel rapporto tra gesto e suono che emerge questa tensione costante: tra innalzamento e cedimento, tra sospensione e collasso. Il movimento non è altro che il tentativo di riconfigurarsi continuamente, in ascolto con ciò che si muove dentro e fuori dal corpo.
Progetti futuri?
Torno al progetto Athletes, con il debutto del quadro coreografico Le Palestriti in anteprima al Kilowatt Festival il 16 luglio e, successivamente, al Festival Danza Estate di Bergamo il 28 agosto. Ispirato al mosaico delle Palestriti di Piazza Armerina – rara raffigurazione di agonismo femminile nell’antichità – il lavoro vede in scena quattro performer che intrecciano danza, sport e vocalità, trasformando il gesto atletico in pratica di ascolto e resistenza. Lo spazio scenico si fa palestra ferina, nell’avvicendarsi di ritualità sospese tra forza e grazia. Prosegue anche la collaborazione con Francesco Giomi per il progetto Berio a colori, realizzato in occasione del centenario della nascita di Luciano Berio. Sarò in scena insieme al violoncellista Claudio Pasceri: il debutto è previsto al Romaeuropa Festival il 3 ottobre, seguito dalle repliche a Firenze, presso Cango, il 13 e 14 dicembre.
Infine, è in fase di sviluppo il duetto Moths, con il musicista Luca Perciballi: un’indagine tra corporeità notturne, transiti e dissolvenze.
Lorena Coppola
Photo Credits: Nexus
www.giornaledelladanza.com
© Riproduzione riservata
 Giornale della Danza La prima testata giornalistica online in Italia di settore
Giornale della Danza La prima testata giornalistica online in Italia di settore