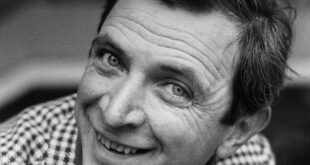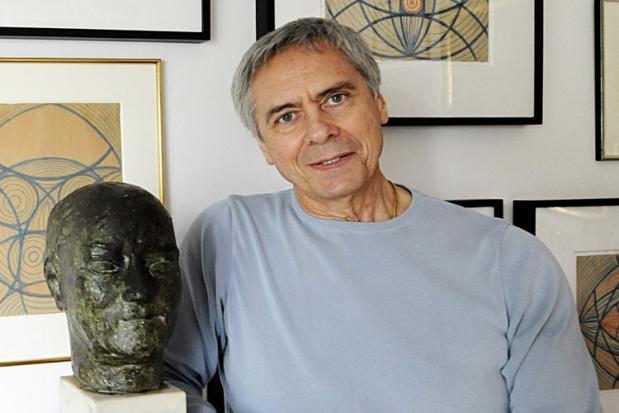Nel grande teatro del balletto classico, le danze di carattere non sono solo ornamento, ma veri e propri frammenti di mondo.
Travestite da folklore, da fiaba o da cerimonia, queste danze si insinuano nella struttura narrativa e scenica dei grandi titoli ottocenteschi, svelando un lato meno noto del virtuosismo accademico: quello che parla la lingua delle culture.
Nei tre capolavori di Čajkovskij – Il Lago dei Cigni, Lo Schiaccianoci e La Bella Addormentata – esse si trasformano in specchi dell’umano, celebrando la varietà e il ritmo della vita.
Nel terzo atto del Lago dei Cigni, la corte celebra un momento solenne: il principe deve scegliere la sua sposa. Ma ciò che si consuma sul palco è qualcosa di più profondo. La scena si trasforma in una galleria di maschere nazionali: una mazurka polacca, una csárdás ungherese, una tarantella napoletana, una danza spagnola. Ogni popolo entra in scena non come entità storica, ma come simbolo, portando con sé profumi, gesti e ritmi stilizzati. Ma il vero scopo di queste danze non è folklorico: sono un velo, un artificio, un teatro dentro al teatro. Sotto i tamburi, i ventagli e i tacchi, si cela la trappola tesa da Rothbart. È in questo contrasto – tra il vigore terrestre delle danze e la purezza ultraterrena di Odette – che il balletto trova una delle sue dicotomie più affascinanti.
Nel secondo atto de Lo Schiaccianoci, la geografia diventa sogno. Le danze non rappresentano nazioni, ma essenze: il cioccolato spagnolo, il caffè arabo, il tè cinese, i bastoncini di zucchero russi. In questo regno dolcissimo e caramellato, ogni danza è un gusto, un colore, un’esplosione di forma. La coreografia è delizia visiva: la danza araba ondeggia come una seta nel deserto; quella cinese è minuta, saltellante, quasi giocosa; il Trepak russo è un turbine di salti e grida, un brindisi danzante.
Queste non sono danze storiche, né realistiche. Sono visioni teatralizzate di culture lontane, filtrate attraverso l’immaginazione occidentale dell’epoca. Ma è proprio nella loro idealizzazione che trovano potenza: trasformano il palcoscenico in un tappeto volante che sorvola l’esotico, mescolando il folklore con l’arte del sogno.
Se ne Lo Schiaccianoci le danze di carattere sono zucchero e sogno, ne La Bella Addormentata esse diventano rito. Marius Petipa orchestra il terzo atto come un banchetto fiabesco: danzano personaggi delle favole, cortigiani, spiriti allegorici. Cappuccetto Rosso balla con il Lupo, il Gatto con gli Stivali seduce la Gattina Bianca, e la polonaise d’apertura è una vera coreografia araldica, un inno alla forma. Qui la danza di carattere si sposa con l’estetica del fasto, della celebrazione. Non c’è più bisogno di evocare terre lontane: tutto accade “in un altro tempo”, in un’epoca sospesa dove la danza diventa celebrazione del bene, della rinascita, del matrimonio tra regno e destino.
Le danze di carattere, nei tre grandi balletti di Čajkovskij, non sono semplici variazioni stilistiche. Sono ponti drammaturgici è maschere della realtà. Nel Lago creano l’inganno, in Schiaccianoci costruiscono la fantasia, in Bella consolidano il mito.
La danza di carattere è la memoria del mondo che bussa alla porta della fiaba. E il balletto, come sempre, apre le braccia e la trasforma in arte.
Nei grandi balletti, le danze di carattere non sono mai fini a sé stesse. Servono ad arricchire la trama, ad ambientare l’azione in un contesto specifico o a caratterizzare certi personaggi.
Se il balletto classico è un’arte che vive di forma e contenuto, le danze di carattere ne sono un’espressione vivace, colorata e profondamente umana.
In esse si ritrova non solo l’eleganza della danza, ma anche le radici dei popoli e delle storie che l’hanno ispirata.
Michele Olivieri
www.giornaledelladanza.com
©️ Riproduzione riservata
 Giornale della Danza La prima testata giornalistica online in Italia di settore
Giornale della Danza La prima testata giornalistica online in Italia di settore