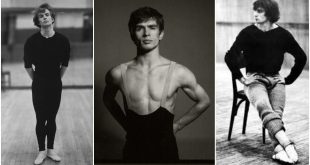Lo chignon, dal francese chignon du cou (“nuca”), esisteva già prima di diventare un tratto distintivo del balletto. Era un’acconciatura diffusa tra le donne europee, sinonimo di eleganza e raffinatezza.
Tuttavia, è nel XIX secolo, durante l’epoca del balletto romantico, che lo chignon assume il suo significato nel mondo della danza, occupando un posto d’onore.
L’arte del balletto evolve verso una rappresentazione sempre più eterea e spirituale, si cerca leggerezza, slancio, ordine. Il corpo diventa strumento espressivo e deve essere libero, armonico, quasi soprannaturale.
Ecco che i capelli vengono raccolti in uno chignon semplice e pulito: non solo per praticità, ma per rafforzare l’estetica di grazia e rigore.
Durante salti, giri e piroette, ogni distrazione può compromettere l’equilibrio o l’espressività. Lo chignon garantisce sicurezza e stabilità.
Ma è anche una questione di forma: i capelli raccolti aiutano a valorizzare la linea del collo e la postura, elementi fondamentali nella disciplina accademica.
Esistono numerose varianti di chignon: alto, basso, intrecciato, con retina o liscio e compatto. In ogni caso rimane un rituale quotidiano, un piccolo gesto che prepara il corpo e la mente all’allenamento e alla scena.
Più che una pettinatura, è diventato un segno distintivo, riconoscibile ovunque. Anche fuori dai teatri, lo chignon evoca immediatamente la figura della ballerina.
Michele Olivieri
www.giornaledelladanza.com
©️ Riproduzione riservata
 Giornale della Danza La prima testata giornalistica online in Italia di settore
Giornale della Danza La prima testata giornalistica online in Italia di settore