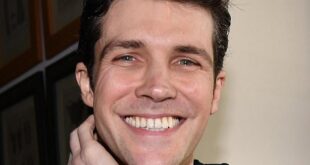Nelle pieghe della storia della danza, il nome di Bronislava Nijinska è spesso avvolto da un’ombra: quella luminosa, ingombrante e tragica del fratello Vaslav Nijinsky.
Eppure, a ben guardare, la sua figura si staglia con una forza autonoma, inconfondibile, nella parabola dell’arte coreutica del Novecento.
Nijinska non fu solo una sorella, né solo una danzatrice. Fu una mente, un’artista completa, capace di incarnare una delle più importanti transizioni della danza: quella dalla grazia idealizzata del balletto classico alla tensione strutturata del moderno.
Nacque a Minsk nel 1891, in una Russia zarista che si preparava inconsapevolmente a crollare. Figlia di ballerini itineranti, crebbe in un ambiente dove l’arte non era lusso, ma sopravvivenza.
La disciplina della danza, rigida e quotidiana, le fu trasmessa come una lingua madre. A soli cinque anni fu ammessa alla Scuola Imperiale di San Pietroburgo, fucina delle étoile dell’Impero.
Qui, tra gli specchi dell’aula e l’eco degli ordini in francese, si formarono le basi della sua visione artistica: non una danza fatta solo di bellezza, ma di struttura, tensione, significato.
La modernità, con le sue fratture, stava entrando nei teatri. E Bronislava ne fu testimone diretta.
A diciassette anni cominciò a danzare con il Balletto Imperiale Russo dove si formò con Enrico Cecchetti, Victor Gillert, Michel Fokine, Klavdia Kulichevskaya, ma fu con l’ingresso nei Ballets Russes di Sergei Diaghilev che la sua traiettoria si fece rivoluzionaria.
Lavorò accanto a geni dell’arte e della musica: Stravinskij, Picasso, Bakst, e naturalmente Vaslav, il fratello divino e tormentato. Quando lui cadde nel silenzio della malattia mentale, lei raccolse il testimone, trasformando il dolore in creazione.
Nijinska cominciò a coreografare: dapprima con esitazione, poi con crescente sicurezza. Il suo stile era nuovo, spigoloso, architettonico. I corpi non erano ornamento ma forma viva.
Bronislava non cercava l’applauso facile. La sua danza non era intrattenimento, ma pensiero in movimento. Proprio per questo, fu spesso meno celebrata di altri colleghi.
In un’epoca in cui il genio maschile era ancora l’unico riconosciuto, lei dovette farsi largo con il doppio del rigore e della forza. Eppure, lasciò un segno profondo.
Le sue coreografie hanno influenzato la danza contemporanea ben oltre la sua epoca.
La sua attività come insegnante formò generazioni di ballerini e coreografi. Tra le personalità di primo piano che studiarono con lei ricordiamo Serge Lifar, Frederick Ashton, Maria Tallchief, Allegra Kent.
La sua visione – fatta di struttura e sentimento, di rigore e libertà – è oggi riconosciuta come una delle radici dell’avanguardia coreografica del Novecento.
In un’intervista, una delle sue allieve disse: “Con lei non si imparava solo a ballare. Si imparava a pensare con il corpo.” Questa, forse, è la più alta definizione della sua arte.
Michele Olivieri
www.giornaledelladanza.com
© Riproduzione riservata
 Giornale della Danza La prima testata giornalistica online in Italia di settore
Giornale della Danza La prima testata giornalistica online in Italia di settore