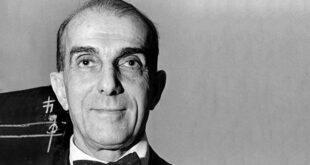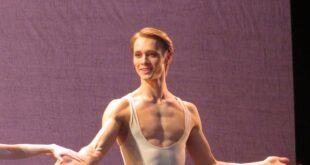Nel grande mosaico culturale del primo Novecento, fatto di rivoluzioni artistiche, guerre, avanguardie e inquietudini, poche figure incarnano lo spirito del tempo come Ida Rubinstein. Non fu solo una danzatrice, né soltanto un’attrice. Non si può definire semplicemente mecenate, né ridurla a musa. Fu tutto questo insieme, e qualcosa di più: un simbolo del decadentismo, della trasgressione, del potere dell’estetica come forma di vita.
A metà tra leggenda e presenza concreta, Ida Rubinstein non era un’artista nel senso tradizionale: la sua arte non stava tanto nella tecnica quanto nella visione, nella presenza scenica, nella capacità di trasformare ogni performance in un evento culturale e simbolico.
Nata a San Pietroburgo nel 1883 da una ricchissima famiglia ebraica di origine polacca, Ida fu orfana in giovane età e cresciuta in un ambiente raffinato, colto e cosmopolita. Parlava correntemente più lingue, studiò arte, letteratura e teatro. Tuttavia, la sua sete di libertà e trasgressione la spinse presto a cercare palcoscenici alternativi a quelli imposti dalla società aristocratica russa.
Il suo debutto artistico fece scalpore: nel 1908, a San Pietroburgo, interpretò Salomè in un adattamento tratto da Oscar Wilde, spogliandosi velatamente in scena. Fu uno scandalo. Ma anche una dichiarazione di poetica: Rubinstein non cercava il consenso, cercava l’eccezionalità. Nel 1909, Sergej Diaghilev la chiamò per la stagione inaugurale dei Ballets Russes a Parigi, accanto a Vaslav Nijinsky e Tamara Karsavina.
Rubinstein danzava Cléopâtre, su coreografia di Michel Fokine, scene e costumi di Léon Bakst. La sua figura longilinea, il volto enigmatico e l’eleganza esotica divennero subito icone dell’estetica orientaleggiante tanto cara all’Art Nouveau. Eppure, il sodalizio con Diaghilev fu breve.
Rubinstein aveva una visione autonoma dell’arte. Non voleva essere diretta, voleva dirigere. Lasciò la compagnia e si mise in proprio, iniziando una carriera in cui sarebbe stata non solo interprete, ma anche produttrice, curatrice, committente. Nei suoi spettacoli, Rubinstein fuse danza, recitazione, musica, pittura e scenografia. Collaborò con i più grandi artisti del tempo: Claude Debussy, Maurice Ravel, Paul Dukas, Gabriel Fauré, Jean Cocteau, Georges Braque, Léonide Massine, Dmitrij Šostakovič. Ogni opera era un’opera totale.
La sua più celebre commissione è senza dubbio il Boléro di Ravel (1928), scritto appositamente per lei. Rubinstein non danzava nel senso tecnico del termine, ma incarnava la musica con movimenti lenti, rituali, sensuali. Il crescendo ipnotico del Boléro, unito alla sua presenza magnetica, trasformò il pezzo in un inno moderno al desiderio e all’ossessione.
Con una fortuna personale considerevole, Ida Rubinstein finanziò molte produzioni che sarebbero state impensabili in un contesto puramente commerciale. Il suo teatro diventava laboratorio di sperimentazione visiva, tra simbolismo, modernismo e un certo spiritualismo decadente. Non cercava il successo popolare, ma l’effetto dirompente, la bellezza assoluta, l’unicità.
Nel 1928 fondò la propria compagnia, Les Ballets Ida Rubinstein, attiva fino al 1935. Le sue produzioni erano sontuose, eccessive, iperestetizzate. Gli intellettuali dell’epoca la ammiravano, anche se talvolta la criticavano per la mancanza di rigore tecnico. Ma per lei la danza era uno strumento di evocazione, non di virtuosismo.
Ida Rubinstein non si sposò mai, non ebbe figli, né una carriera “ordinata”. Frequentò i salotti parigini e le avanguardie, ebbe relazioni con uomini e donne (tra cui la poetessa Renée Vivien, secondo alcune fonti), sfidando le convenzioni del tempo con uno stile di vita libero, intellettualmente feroce, spesso solitario. Durante la Seconda Guerra Mondiale fuggì in Inghilterra. Ritiratasi dalle scene, visse in relativo isolamento fino alla sua morte a Vence, in Provenza, nel 1960.
Oggi Ida Rubinstein è una figura quasi mitica, ma il suo impatto sull’arte del Novecento è stato profondo, anche se sotterraneo. Fu tra le prime a concepire la danza come forma multidisciplinare, visione che avrebbe anticipato il teatro-danza e l’arte performativa. Fu anche un modello di autonomia femminile nel mondo artistico, in un’epoca in cui le donne erano spesso relegate a ruoli secondari o decorativi.
Rubinstein si impose come produttrice, interprete, imprenditrice e ideatrice, seguendo la sua estetica personale, anche a costo dell’incomprensione. Ida Rubinstein non fu mai del tutto compresa, e forse era questo il suo desiderio. Rimase un enigma, una figura sospesa tra passato e futuro, tra danza e teatro, tra devozione spirituale e sensualità estrema. Ida non voleva essere amata. Voleva essere ricordata. E c’è riuscita — non come una tecnica, ma come un’idea.
Quando Ida Rubinstein apparve sul palcoscenico della Scala nel 1911, Milano non era pronta. Nei suoi spettacoli – Cleopatra e Shéhérazade – non c’era solo danza: c’era mistero, sensualità, scenografie opulente e una teatralità che rompeva con la compostezza accademica italiana. La sua figura, slanciata e ieratica, era già leggenda a Parigi; a Milano, divenne scandalo.
Portava in scena un’estetica nuova, che fondeva corpo e pittura, musica e mito. Non era una ballerina nel senso tradizionale: era un’apparizione, una performance vivente, una visione tra simbolismo ed esotismo. Gli abiti firmati Bakst, le coreografie di Fokine, le musiche di Rimskij-Korsakov e Ravel trasformavano il palcoscenico in un sogno onirico.
Nel 1929 tornò al Teatro alla Scala con la sua compagnia e un repertorio ambizioso: La Valse, Il bacio della fata, Boléro. Quest’ultimo – scritto per lei da Ravel – fu il più acclamato: un crescendo ipnotico dove Rubinstein, quasi immobile, magnetizzava lo sguardo del pubblico. Eppure, la sua arte divideva. Troppo moderna per alcuni, troppo visiva per altri. Ma proprio in quella frattura stava il suo potere: scardinava certezze, apriva spazi per una danza che fosse rito, immagine, evocazione.
Alla Scala, Ida Rubinstein non cercò consensi. Portò un’idea di teatro che disturbava, ma lasciava un segno. E quel segno — audace, colto, femminile e indecifrabile — continua a vibrare nelle assi di quel palcoscenico. La sua presenza al Piermarini è ricordata non tanto per la tecnica — che molti critici giudicavano imperfetta — ma per la capacità di incarnare, attraverso la presenza scenica, la tensione estetica di un’epoca: tra orientalismo, simbolismo, modernismo, desiderio di rottura.
Il suo passaggio alla Scala conferì slancio alle compagnie locali nell’aggiornarsi, incoraggiò scenografi, costruttori di scene, critici — insomma, l’intera filiera teatrale — a riflettere su quanto importasse l’immagine, la scenografia, la luce, il costume.
Michele Olivieri
www.giornaledelladanza.com
© Riproduzione riservata
 Giornale della Danza La prima testata giornalistica online in Italia di settore
Giornale della Danza La prima testata giornalistica online in Italia di settore